Quando la pezza è peggio del buco: John Ashfield e la brand reputation
L’antefatto: nell’aprile 2009 il blog “Altezzosa e poco loquace”, diario online della caustica Arianna Cavazza aka Sybelle, pubblica un post che critica aspramente un visual publicitario di John Ashfield (che possiamo ammirare in tutta la sua magnificenza nella foto qui sopra).
La pagina pubblicitaria è a dir poco imbarazzante, ma non è questo il punto.
Dopo qualche mese, tra i commenti al post, compare una testimonianza piuttosto velenosa, di un presunto ex dipendente (anonimo) che critica aspramente l’azienda in quanto spaccia i capi per abbigliamento prodotto in Inghilterra o Scozia, quando invece “la produzione vera e propria è fatta perlopiù in Bangladesh e relativi Stati, dove la manodopera costa un fico secco…“. E da qui inizia una sorta di dramma in salsa 2.0.
Dopo qualche mese di silenzio, evidentemente qualcuno all’interno dell’azienda scopre il tutto: a cavallo tra 2009 e 2010 la pagina si popola di commenti pro-John Ashfield, da parte di presunti clienti ventennali, titolari di punti vendita, dipendenti… tutti più che convinti della qualità dei capi e dell’onestà del brand, tutti stupiti che si possa gettare fango su un’azienda “che ci dà da mangiare ogni giorno“.
Tra i tanti spicca una minaccia di uno dei responsabili delle vendite: “Sono inoltre a comunicare al personaggio in questione che il legale dell’azienda per un periodo di anni archivia tutti i dati personali di dipendenti passati ed attuali, non sarà quindi difficile risalire prossimamente al colpevole delle maldicenze“.
Ma, signori e signori, non finisce qui: il post viene censurato. Scompare. WordPress accoglie le richieste dell’azienda, e senza pensarci troppo rende irreperibile la pagina. Ma non abbiamo ancora finito: John Asfield, l’azienda che prende ispirazione dai gentleman britannici, più che esperta nell’utilizzo di mazze da cricket pare sia esperta nell’utilizzo di zappe sui piedi.
Il 20 febbraio, a quasi 10 mesi dal post che ha dato fuoco agli animi, esce sul blog di Alessandro Gilioli Piovono Rane (gruppo L’Espresso) una lettera di tale Alessandro Celli, titolare dell’azienda in questione. La lettera diverrà parte integrante di tutti i corsi di comunicazione aziendale e brand reputation, ne siamo certi.
Ecco alcuni succosi passaggi: si va dal tono di chi si è offeso (vorrei capire perché ha fatto questo e quale vantaggio può esserle venuto da questa situazione) alla critica stile “fratello maggiore” (Le dico che nella vita non basta aprire un blog per realizzarsi criticando quello che fanno gli altri).
C’è anche un bonario tentativo di collaborazione: “Quindi Le chiedo sinceramente di aiutarmi in prima persona a far cessare tutto questo casino che è scaturito dal mondo di Internet contro la mia azienda“.
Ma anche alcune critiche piuttosto forti: “…affermazioni anonime sulla nostra azienda, lesivi e diffamanti della nostra immagine e della nostra organizzazione aziendale e produttiva, di cui Lei non sa e non può sapere nulla, senza che Lei ne abbia controllato la veridicità”.
E prima di concludere difendendo l’onestà del brand, specificando senza la minima prova che i capi non sono prodotti in paesi con manovalanza a buon mercato, la lettera presenta anche un immancabile, seppur velato, tono intimidatorio: “Questa è una Sua responsabilità, perché gettare fango ad una azienda è troppo facile rimanendo nell’ anonimato e sfruttando il Suo blog per tali scopi“.
Quindi, ricapitoliamo: la strategia per rispondere alle critiche è:
- Riempire il post di commenti, con vari nickname, difendendo la reputazione del marchio;
- Per sicurezza, fare pressione al blog provider affinché oscuri la pagina;
- Pubblicare una lettera aperta (dopo la censura), dal tono tra il bonario e l’offeso, per mettere le cose a posto una volta per tutte.
Sono ancora pochi i casi eclatanti, nella nostra Penisola, di marketing difensivo dove la pezza fa molto peggio del buco. Dall’America, invece, ne sono arrivate di tutti i tipi.
Se vogliamo vederle come case history per un ipotetico (e sopracitato) corso di brand reputation, abbiamo diversi tematiche hot: dal “Come non gestire i reclami semplicemente non rispondendo, by united Airlines”, al “Come non controllare i propri dipendenti idioti, by Domino’s e Comcast”. Interessante anche il “Come farsi del male pagando la gente per mettere feedback positivi su Amazon.com, by Berkin” o il “Come creare disastri non sapendo gestire l’user generated, by, Chevrolet”. Ma non vale la pena dilungarsi: sono casi di studio iper-noti, e li trovate tutti qui e qui.
Come testimonia questa foto d’epoca (risalente al primo lustro del nuovo millennio), sono stati i fastfood i primi a sperimentare i disastri virali provocati dal pubblico, quando si mette di impegno nel criticare prodotti e servizi. Una delle reazioni più geniali è stata di Burger King (con l’agenzia Crispin Porter + Bogusky) quando giocò all’attacco proponendo la “Angus diet”, il lifestyle basato sul consumo di carne, a chi considerava il cibo fast food poco salutare.
A distanza di anni, però, pare che non tutti abbiano imparato a reagire con creatività ed ironia. E non facciamo nomi, c’è gente che censura in giro…
http://www.ninjamarketing.it/2010/03/08/quando-la-pezza-e-peggio-del-buco-john-ashfield-e-la-brand-reputation/
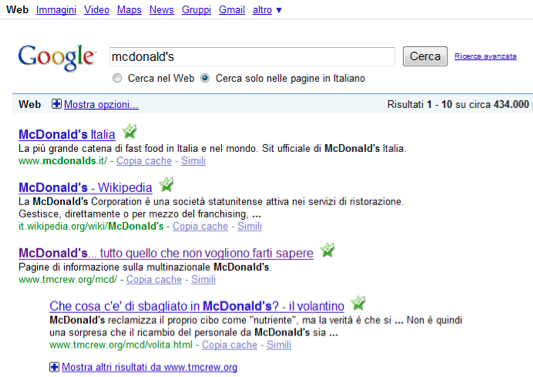
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.